Da 12 anni di prigionia nell'URSS, Enrico Reginato, Edizioni Canova, Treviso
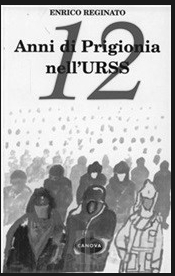 Gli orrori del campo di Oranki si moltiplicarono con l'arrivo dei prigionieri rumeni. Il 18 dicembre 1942, una giornata rigidissima, durante la quale il termometro segnò oltre trenta gradi sotto zero, affluì al campo una colonna di tremila uomini. Arrivarono dopo un mese di viaggio, a piedi e in treno. Al seguito della colonna procedeva lento sulla neve il triste corteo delle slitte sulle quali erano accatastati gli infermi e gli invalidi.
Gli orrori del campo di Oranki si moltiplicarono con l'arrivo dei prigionieri rumeni. Il 18 dicembre 1942, una giornata rigidissima, durante la quale il termometro segnò oltre trenta gradi sotto zero, affluì al campo una colonna di tremila uomini. Arrivarono dopo un mese di viaggio, a piedi e in treno. Al seguito della colonna procedeva lento sulla neve il triste corteo delle slitte sulle quali erano accatastati gli infermi e gli invalidi.
Nel breve percorso dalla stazione al campo, quei poveri esseri umani si irrigidirono come pezzi di legno. Furono trasportati in uno stanzone chiamato club, perché abitualmente usato per i convegni di propaganda comunista. In quel locale, dove oratori fanatici parlavano di fratellanza e solidarietà fra i popoli, vidi morire centinaia di uomini.
Stesi sul nudo pavimento, al contatto col tepore, i corpi - rigidi come tronchi - si scioglievano. Gli arti ricominciavano a muoversi, le bocche emettevano lamenti. Chi aveva un po' di forza strisciava per terra, aiutandosi con i gomiti, verso la stufa. Qualcuno posava le mani, rese insensibili dal freddo, sulla lamiera arroventata e le ritraeva orribilmente ustionate. Conscio del pericolo a cui erano esposti per l'improvviso sbalzo della temperatura, feci spegnere la stufa. Rimasi tutta la notte in piedi fra i sofferenti, impotente a frenare la spaventosa ecatombe. In poche ore decine e decine di soldati si spensero passando dal torpore alla morte senza riprendere conoscenza.
I portaferiti lavoravano in silenzio, indifferenti come monatti. Esausti per la fatica, non si caricavano più sulle spalle i corpi inanimati: li trascinavano per i piedi, giù dalle scale. E io udivo il tonfo sinistro della testa dei cadaveri che batteva di gradino in gradino.
Quando si levò il pallido sole, i primi raggi illuminarono nel cortile una catasta di oltre quattrocento morti. Gli stessi Russi non rimasero insensibili di fronte a quella scena macabra; ai Rumeni non ospedalizzati somministrarono un'abbondante razione di zuppa e di pane che fu fatale per molti perché, dopo tanto digiuno, scatenò diarree irrefrenabili.
Normalizzata un po' la situazione, con l'aiuto del tenente Joli pensai alle cure dei ricoverati. Nel club erano rimasti oltre duecento invalidi, colpiti da cancrena alle mani, ai piedi, alle braccia, alle gambe. Con lo sfacelo delle carni si diffondeva nello stanzone un fetore nauseabondo.
Invocai dalla direzioni sanitaria del campo bende e medicinali, ma senza risultato. Le mie richieste venivano accolte, ma la trafila burocratica finiva per insabbiarle. Per la disinfezione delle piaghe potevo usare il permanganato che non mancava mai. Per favorire la demarcazione della cancrena e la granulazione dei tessuti, adottai l'olio minerale che mi fu dato con difficoltà e in misura scarsa. I sanitari russi di fronte a queste cure di emergenza erano scettici.
Obiettivamente devo riconoscere che alcuni sanitari sovietici assecondarono il mio lavoro, ma essi stessi non riuscivano a smuovere le autorità centrali: impossibile un rapido rifornimento di letti, di pagliericci e soprattutto di medicinali. In quelle condizioni disastrose cominciai la mia opera di chirurgo. Il modesto strumentario dell'ospedaletto principale non era mai disponibile. Lamette di rasoio sostituirono il bisturi, una sega da fabbro mi servì come sega chirurgica. Mi giovai di corde di violino per compiere suture.
Applicai questa chirurgia primitiva sul corpo di un soldato rumeno di nome Venescu. Un ragazzo gracile di costituzione, forse non ancora ventenne, bruno e talmente smagrito che si sarebbe potuto sollevare dal suo giaciglio senza alcuno sforzo. Mani e piedi erano neri per la cancrena. Dalle sue labbra usciva a intermittenza un flebile lamento, non di dolore, ché la cancrena - resi insensibili i tessuti - non lo faceva soffrire, ma di raccapriccio, disperazione per lo stato spaventoso delle sue carni decomposte. Si guardava le mani e gemeva.
Venescu giaceva a terra, sopra un po' di paglia, primo della terza fila di degenti nello stanzone del club.
Quando gli passavo accanto sentivo il suo supplice richiamo: "Tatà, tatà." ["Papà, papà", n.d.r.]
"Come va, Venescu?" gli chiedevo dolcemente. Mi mostrava le mani incancrenite e mormorava con un filo di voce che mi inteneriva: "Tatà, tatà." Fasciai spesso le sue mani e i suoi piedi. La mia sola presenza lo rianimava e con un sorriso esprimeva la sua gratitudine.
Ero commosso per la devozione che questo ragazzo mi dimostrava e appena avevo un po' di tempo libero, mi avvicinavo e gli accarezzavo la fronte. [...]
La cancrena progrediva. Le mani erano un groviglio orribile di tendini e di ossa che affioravano dalle carni in sfacelo. Bisognava ricorrere all'amputazione, recidendo all'altezza del polso, dove i tessuti cominciavano a demarcarsi. Eseguii l'operazione con una forbice poco tagliente e una lametta da rasoio. Mentre disarticolavo le ossa, Venescu non gemeva. Ripeteva invariabilmente la sua invocazione, con gemito infantile: "Tatà, tatà."
Poi fu la volta dei piedi. Mentre agli arti superiori i tessuti ancora sani e granuleggianti consentivano di rivestire il moncone, ai piedi la necrosi aveva raggiunto la parte estrema della gamba. Un manicotto rossastro si era formato all'altezza del terzo inferiore della tibia che sporgeva biancheggiante dalla carne scarlatta. Era necessario asportare quell'osso, urgentemente. Il fabbro del campo mi fornì la sega che disinfettai tenendola a lungo nell'acqua bollente.
Venescu sopportò lo stridore del ferro sulla tibia come aveva sopportato lo strazio delle sue carni. Nei giorni seguenti sembrava sollevato, nonostante le paurose mutilazioni. Il rigonfiamento terminale degli arti lentamente si ricopriva di lembi di cute, tenuti insieme con frammenti di corda di violino.
Il miracolo della ripresa si compiva. Le risorse di un organismo ancora giovane si manifestavano prodigiosamente. Consolavo Venescu, dicendogli che una volta rimpatriato avrebbe potuto farsi applicare mani e piedi artificiali. Sarebbe stato così in grado di camminare da solo. Con questa speranza si sforzò di mangiare la zuppa che Joli gli porgeva, imboccandolo. Venescu sognava il giorno del rimpatrio. Fantasticava. Si vedeva già alle prese con un falegname del suo villaggio, incaricato di costruirgli gli arti di legno, e chiedeva a noi come avrebbe potuto mettere le scarpe sui piedi artificiali.
Poi Venescu fu trasportato in un altro ospedale che accoglieva i convalescenti. Non pensai più a lui, assorbito com'ero dall'enorme lavoro. Due mesi dopo un Rumeno che sapeva con quanta sollecitudine mi ero dedicato all'assistenza del suo connazionale, mi annunziò addolorato: "Questa notte hanno riportato Venescu: sta molto male." Andai a visitarlo. Giaceva raggomitolato sotto le coperte di un lettino dove consumava, in una lenta agonia, le ultime forze.
Quando gli fui vicino aprì gli occhi offuscati, quasi spenti. Mi riconobbe. Lo accarezzai sulla fronte e le sue labbra accennarono la parola con la quale mi invocava al suo letto: "Tatà, tatà." Poche ore più tardi quelle labbra esangui tacquero per sempre.